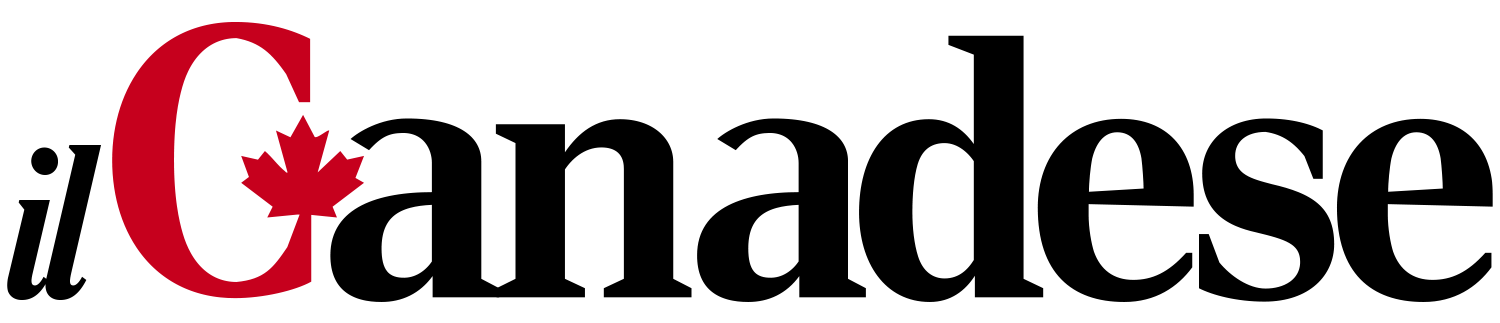Andrea Domenici, nato a Lecco e trasferitosi a New York nel 2012, è un pianista, compositore e arrangiatore di jazz che ha già conseguito importanti riconoscimenti internazionali. Tra i suoi titoli figurano la vittoria della prima edizione del «Premio Gianni Basso» come miglior solista e il primo premio al «La Spezia Jazz Competition» come miglior pianista. Dopo aver conseguito un bachelor alla The New School for Jazz and Contemporary Music e un master alla The Juilliard School, ha collaborato e condiviso il palco con artisti del calibro di Wynton Marsalis, Roy Hargrove, Peter Washington e Billy Drummond. Il suo album di debutto come leader, Playing Who I Am, vede la partecipazione di Peter Washington al basso e Billy Drummond alla batteria. Attualmente si esibisce regolarmente come pianista residente a New York e continua a sviluppare progetti di composizione e reinterpretazione del repertorio jazz. Lo abbiamo intervistato per IINewyorkese.
Come nasce il tuo percorso musicale e cosa ti ha portato a trasferirti a New York?
È iniziata in famiglia, da una passione di mio padre. Poi ho trovato un insegnante che mi ha aiutato molto, di nome Mario Rusca, il quale mi ha insegnato a suonare il pianoforte. Poi ho conosciuto dei musicisti che erano stati a New York, uno di questi è Dado Moroni che è stato il mio mentore per molti anni. New York rappresentava la destinazione naturale: è una città dove il jazz è vivo in ogni angolo, dove puoi ascoltare e suonare ogni giorno, imparando continuamente. Mi sono trasferito nel 2012 sono andato prima alla The New School for Jazz and Contemporary Music dove ho fatto il mio Bachelor e poi ho fatto il Master alla The Juilliard School successivamente. Quell’esperienza mi ha permesso non solo di crescere artisticamente, ma anche di costruire un mio linguaggio musicale, in equilibrio tra le radici italiane e la libertà dell’improvvisazione americana.
Come descriveresti la tua musica e le influenze che l’hanno formata?
Sicuramente la tradizione jazz americana, con i grandi pianisti che ho studiato e amato – da Bill Evans a Herbie Hancock hanno dato un grande contributo. Finiti gli studi, è uscito il mio primo disco da leader in trio con Peter Washington al contrabbasso e Billy Drummond alla batteria, chiamato Playing Who I Am. Quando ho registrato Playing Who I Am, volevo un suono autentico, senza artifici: tre persone in una stanza, che dialogano attraverso la musica. È stato esattamente così. Il titolo riflette proprio questo: suonare chi sono, senza compromessi, con sincerità ma anche con uno sguardo personale. Uno si intitola For Kenny, che è dedicato al pianista Kenny Barron che è stato uno dei miei insegnanti qui negli Stati Uniti per cui sono molto legato e gli ho dedicato un brano. Poi c’è un pezzo che si chiama Daniela che era dedicato a mia zia che era scomparsa da poco. Probabilmente For Kenny è il pezzo che ha avuto il risultato più riuscito. C’è della bella energia in quel brano.
Come tu vedi il futuro del jazz in una città che vive anche di tanta musica commerciale e pop?
Ho notato che dopo la pandemia la gente si è abituata a guardare i telefoni e gli schermi costantemente. La capacità di attenzione di qualsiasi persona, a parte le conoscenze musicali in generale, è calata drasticamente. Quando suonavo prima della pandemia in diversi posti di New York mi rendevo conto che c’era più partecipazione, più volontà di ascolto, più focus dell’ascoltatore. Mentre secondo me dopo la pandemia questo aspetto è cambiato. Molti locali di New York, che non sono jazz-club, vogliono il jazz per una questione d’immagine, non perché le persone vogliano realmente ascoltare musica. Ci sono certi luoghi a New York, come Village Vanguard, dove fortunatamente ancora si spinge all’ascoltatore ad ascoltare.
Com’è oggi l’esperienza nei locali jazz della città e quali sono quelli a cui ti senti più legato?
Oggi andare nei club di New York è molto diverso da com’era anche solo dieci o quindici anni fa. Non sempre l’ambiente è davvero “musician friendly”. Tra i club che preferisco c’è senza dubbio Mezzrow un locale piccolo e raccolto, quasi “religioso”, dove regna ancora il silenzio e il rispetto per la musica, con una programmazione sempre curata e strumenti di ottima qualità. Il suo “gemello” è lo Smalls, che adoro anche se ha un’atmosfera più sportiva. Mezzrow, invece, conserva un fascino d’altri tempi: mi ricorda i club degli anni ’90, come il leggendario Bradley’s, che si trovava su University Place vicino a Union Square e dove sono cresciuti molti musicisti della vecchia guardia. Non l’ho mai visto di persona, ma tutti me ne hanno parlato con un misto di nostalgia e rispetto. In un certo senso, Mezzrow ne rappresenta l’eredità.
Come vedi oggi l’evoluzione del jazz e il futuro del mestiere di musicista, tra influenze nuove e la tradizione che resiste?
Il jazz è un linguaggio vivo, aperto alle contaminazioni. Poi se le influenze siano positive o meno, quello dipende dai gusti. Io credo però che il jazz mantenga sempre una sua identità precisa, che ruota intorno allo swing, al suo aspetto ritmico. È quello che per me resta fondamentale: puoi cambiare armonie, linguaggi, strumenti, ma lo swing è ciò che rende il jazz riconoscibile e vitale.A New York, quando vai in un club quella pulsazione la senti ancora. È ciò che voglio mantenere anche nella mia musica. Non mi considero un tradizionalista, amo le sfumature e le nuove influenze, ma quando ascolto qualcosa di improvvisato senza swing, mi allontano istintivamente. Non mi cattura. È come se mancasse la linfa vitale.
Oltre alla tua attività da musicista, ti stai anche occupando della direzione dello Chopin & Friends Festival…
Lo Chopin & Friends Festival ed è un progetto bellissimo che porto avanti con mia moglie, la pianista classica Rodoslawa Jasik. È un festival storico, nato 25 anni fa, ma di recente è cambiata la gestione: l’ex presidente, ormai anziano, si è ritirato e ci ha chiesto se volevamo continuare a farlo vivere. Abbiamo accettato con entusiasmo. La nostra prima edizione come direttori è stata lo scorso anno, e abbiamo deciso di mantenere la struttura su tre concerti. Inoltre sarà in un mese particolare, perché celebra sia il Polish Heritage Month sia l’Italian Heritage Month. Ci è sembrato naturale unire questi due mondi — io italiano, lei polacca — dentro uno spazio comune dedicato a Chopin, ma anche agli artisti che da lui si sono lasciati influenzare. Lo scorso anno abbiamo invitato il pianista Alberto Nosè, vincitore di una delle passate edizioni del Concorso Chopin di Varsavia, che ha tenuto un recital straordinario. Quest’anno il programma include un trio di violino, violoncello e pianoforte, un duo polacco di cantante e pianista, e un concerto che ho curato personalmente in omaggio a Oscar Peterson, nel giorno del suo anniversario di nascita. Sul palco con me ci saranno John Hasselback III alla tromba, Peter Washington al contrabbasso e Ulysses Owens Jr alla batteria. A chiudere il festival, il 24 novembre, sarà il pianista italiano Luca Filastro, con un programma che intreccia musica classica — da George Gershwin a Chopin — e jazz. Il festival è organizzato con il sostegno del Consolato Polacco e con il patrocinio del Consolato Italiano. Sono molto entusiasta di questa iniziativa.
Cosa ti affascina di più del potere della musica?
Quello che amo della musica è che ti obbliga ad essere onesto. Quando suoni non puoi mentire, non puoi nasconderti. La musica parla da sola: o arriva, o non arriva. Non c’è modo di manipolarla. Per questo dico sempre che è bianca o nera, non esiste una zona grigia. E anche se ogni emozione può influenzarti, non sempre riesci a suonare in ogni stato d’animo. Mi serve una connessione sincera, un equilibrio. Ma proprio per questo la musica è così speciale: ti mette davanti a te stesso, ti costringe a essere autentico. In un mondo dove tutto è filtrato o costruito, la musica resta una delle poche esperienze in cui puoi e devi essere vero.
L’articolo Andrea Domenici, dal jazz italiano alla scena di New York proviene da IlNewyorkese.